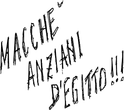Casale Monferrato
21 febbraio 2023
Foto
Resoconto
Appunti di visita: Casale Monferrato
Con un pullman pieno siamo partiti alla volta di Casale Monferrato avendo come prima tappa la sua sinagoga e la sua storia.
Attualmente sono rimaste solo due famiglie: quella della signora che ci accoglierà nella sinagoga e il cui marito è molto avanti negli anni e quella del loro figlio. In totale sette persone. Il ghetto risale agli anni 1710 – 1720.
La sinagoga non poteva avere accesso dalla via principale. Con l’avvento delle leggi razziali del 1938 ci fu l’espulsione degli ebrei da tutte le scuole del regno e, nel 1943, la deportazione con milioni di persone spostate per chilometri su carri bestiame. La famiglia della signora che ci accoglie fu salvata da abitanti di Casale che, pur non conoscendoli, misero a repentaglio anche le loro vite.
Entrando colpisce una tenda, realizzata da Emanuele Luzzati (pittore e scenografo); la tenda accompagnava l’arca.
Se c’è la luce accesa entro l’armadio significa che i rotoli della legge sono presenti.
E’ un ambiente ricco di lampadari e di un grande pulpito bianco che, in realtà è una cantoria.
I casalesi erano bravi artigiani famosi per lavorare il ferro battuto e il cancello che limita la zona sacra ne è testimonianza.
Nel 1943 la sinagoga fu spogliata di ogni oggetto fra i 400 e gli 800 kg di bronzo e tutto fu fuso.
Cambiamo guida (un’insegnante innamorata della storia ebraica) e saliamo a vedere il matroneo dove potevano stare le donne poiché considerate impure a causa del ciclo mestruale.
Abbiamo potuto ammirare il punto “raso” ottenuto lasciando in sospeso i fili dei vari colori: un lavoro davvero certosino.
Durante la seconda guerra mondiale, nella piccola stanza in cui ci troviamo, la guida del museo ci informa che una maestra era riuscita a salvare due classi di bambini delle elementari tenendoli in silenzio e con i nazisti che erano in piazza. Più tardi riuscirà a spostare i bambini in un casale abbandonato e a salvarli tutti.
Da notare che una suora dell’ospedale aveva denunciato il medico perché ebreo.
Gli ebrei osservanti pongono sullo stipite destro delle loro case (e a volte anche negli alberghi) una scatoletta leggermente inclinata alla stessa altezza dal pavimento e dal soffitto.
Nel 1492, sotto Isabella d’Aragona, sono arrivati a Casale ebrei Askenaziti provenienti dal Sud Italia (dal regno Borbonico).
La Toràh, il testo sacro, non si può toccare con le mani e viene arrotolata usando dei puntali (rimmon) e ricoperta con cotonina prima che le venga posta una corona.
La corona non viene mai usata né posata sul capo di alcuno.
Sui puntali ci sono i frutti del melograno.
I semi contenuti nel frutto sono 613.365 pari ai precetti che devi seguire, 248 (le ossa del corpo umano) ma ancora precetti da seguire.
La Torah non si può buttare, si deve regalare a un museo o seppellirla in un cimitero.
La Torah è scritta su pelle di animali, con penna d’oca da amanuensi e non sono ammesse cancellazioni.
La “Festa delle capanne” richiama i 40 anni trascorsi nel deserto. In prossimità di una capanna, fatta di canne di bambù, compare una poltroncina.
E’ riservata al profeta Elia ma veniva anche impiegata per la circoncisione dei neonati che dovrebbe avvenire entro 8 giorni dalla nascita.
Il pane azzimo serve a ricordare che era stato dimenticato il lievito durante la fuga dall’Egitto.
Con lo statuto Albertino del 1848 venne data la possibilità di frequentare la sinagoga ed erigere templi di altre religioni.
La stessa mole Antoneliana, simbolo di Torino, era stata pensata all’origine come sinagoga.
I Casalesi vollero omaggiare il re, essendo Casale la seconda città dopo Torino, facendo erigere una statua a cavallo che da nome alla piazza.
Famosa la battuta di Vittorio Emanuele II che, guardando il personaggio a cavallo, ebbe a dire “accipicchia, non ho mai visto mio padre con la tunica”.
Magnifica la chiesa di Santa Maria di Piazza, modello decorativo del medioevo, luogo di accoglienza, con un piatto verde incastonato nella facciata.
In passato ci fu tensione fra Casale e Alessandria poiché nel 1015 furono rubate le spoglie di Sant’Eusebio e un galletto segnavento.
Oggi si fanno biscotti a forma di galletto oltre che i famosi Krumiri Rossi.
Casale appartiene alla diocesi di Vercelli.
Il santo protettore del Piemonte è Sant’Eusebio. All’interno della chiesa si nota un atrio molto alto con uno spazio che richiama l’agorà e lo stile armeno.
C’è un fonte battesimale molto particolare dove domina l’azzurro.
In una nicchia anche una scultura che rappresenta il diavolo.
In piazza Castello si trova il convento degli agostiniani ora museo civico e gipsoteca.
Il Castello è considerata una struttura militare molto interessante e fu caserma fino al 1999 quando il comune l’acquistò e ora viene usata per mostre e biblioteca per bambini.
Presenta due chiostri di cui uno è detto dei morti.
Ora è un complesso museale dopo la soppressione degli ordini religiosi sotto Napoleone.
Il Castello ha un fossato senza acqua: è stato costruito con aperture per le bombarde a sei diversi livelli d’altezza.
Un camino disperdeva velocemente i fumi delle bombarde. E’ rimasta una fortezza inviolata.
Una pecularietà del luogo è la presenza di “marna” da cui si ricava calce da cemento e per questo era chiamata la città bianca.
Nel periodo Napoleonico in Italia c’erano circa 25.000 ebrei che tra il venerdì Santo e la Pasqua potevano essere malmenati.
Nel “Museo dei Lumi”, nella parte più bassa della sinagoga, si possono vedere molte Menorah di forme diverse realizzate da vari artisti (Luzzati, Pomodoro, ecc.)
Quello che hanno in comune sono le sette braccia a simboleggiare la creazione con sei giorni di lavoro e uno di riposo.
Uno stoppino centrale detto “servitore” permette di accendere le tre + tre candele laterali.
Dopo la sinagoga e prima della visita a Casale, un ricco gustoso pranzo molto apprezzato.
Gemma Casanova
Con un pullman pieno siamo partiti alla volta di Casale Monferrato avendo come prima tappa la sua sinagoga e la sua storia.
Attualmente sono rimaste solo due famiglie: quella della signora che ci accoglierà nella sinagoga e il cui marito è molto avanti negli anni e quella del loro figlio. In totale sette persone. Il ghetto risale agli anni 1710 – 1720.
La sinagoga non poteva avere accesso dalla via principale. Con l’avvento delle leggi razziali del 1938 ci fu l’espulsione degli ebrei da tutte le scuole del regno e, nel 1943, la deportazione con milioni di persone spostate per chilometri su carri bestiame. La famiglia della signora che ci accoglie fu salvata da abitanti di Casale che, pur non conoscendoli, misero a repentaglio anche le loro vite.
Entrando colpisce una tenda, realizzata da Emanuele Luzzati (pittore e scenografo); la tenda accompagnava l’arca.
Se c’è la luce accesa entro l’armadio significa che i rotoli della legge sono presenti.
E’ un ambiente ricco di lampadari e di un grande pulpito bianco che, in realtà è una cantoria.
I casalesi erano bravi artigiani famosi per lavorare il ferro battuto e il cancello che limita la zona sacra ne è testimonianza.
Nel 1943 la sinagoga fu spogliata di ogni oggetto fra i 400 e gli 800 kg di bronzo e tutto fu fuso.
Cambiamo guida (un’insegnante innamorata della storia ebraica) e saliamo a vedere il matroneo dove potevano stare le donne poiché considerate impure a causa del ciclo mestruale.
Abbiamo potuto ammirare il punto “raso” ottenuto lasciando in sospeso i fili dei vari colori: un lavoro davvero certosino.
Durante la seconda guerra mondiale, nella piccola stanza in cui ci troviamo, la guida del museo ci informa che una maestra era riuscita a salvare due classi di bambini delle elementari tenendoli in silenzio e con i nazisti che erano in piazza. Più tardi riuscirà a spostare i bambini in un casale abbandonato e a salvarli tutti.
Da notare che una suora dell’ospedale aveva denunciato il medico perché ebreo.
Gli ebrei osservanti pongono sullo stipite destro delle loro case (e a volte anche negli alberghi) una scatoletta leggermente inclinata alla stessa altezza dal pavimento e dal soffitto.
Nel 1492, sotto Isabella d’Aragona, sono arrivati a Casale ebrei Askenaziti provenienti dal Sud Italia (dal regno Borbonico).
La Toràh, il testo sacro, non si può toccare con le mani e viene arrotolata usando dei puntali (rimmon) e ricoperta con cotonina prima che le venga posta una corona.
La corona non viene mai usata né posata sul capo di alcuno.
Sui puntali ci sono i frutti del melograno.
I semi contenuti nel frutto sono 613.365 pari ai precetti che devi seguire, 248 (le ossa del corpo umano) ma ancora precetti da seguire.
La Torah non si può buttare, si deve regalare a un museo o seppellirla in un cimitero.
La Torah è scritta su pelle di animali, con penna d’oca da amanuensi e non sono ammesse cancellazioni.
La “Festa delle capanne” richiama i 40 anni trascorsi nel deserto. In prossimità di una capanna, fatta di canne di bambù, compare una poltroncina.
E’ riservata al profeta Elia ma veniva anche impiegata per la circoncisione dei neonati che dovrebbe avvenire entro 8 giorni dalla nascita.
Il pane azzimo serve a ricordare che era stato dimenticato il lievito durante la fuga dall’Egitto.
Con lo statuto Albertino del 1848 venne data la possibilità di frequentare la sinagoga ed erigere templi di altre religioni.
La stessa mole Antoneliana, simbolo di Torino, era stata pensata all’origine come sinagoga.
I Casalesi vollero omaggiare il re, essendo Casale la seconda città dopo Torino, facendo erigere una statua a cavallo che da nome alla piazza.
Famosa la battuta di Vittorio Emanuele II che, guardando il personaggio a cavallo, ebbe a dire “accipicchia, non ho mai visto mio padre con la tunica”.
Magnifica la chiesa di Santa Maria di Piazza, modello decorativo del medioevo, luogo di accoglienza, con un piatto verde incastonato nella facciata.
In passato ci fu tensione fra Casale e Alessandria poiché nel 1015 furono rubate le spoglie di Sant’Eusebio e un galletto segnavento.
Oggi si fanno biscotti a forma di galletto oltre che i famosi Krumiri Rossi.
Casale appartiene alla diocesi di Vercelli.
Il santo protettore del Piemonte è Sant’Eusebio. All’interno della chiesa si nota un atrio molto alto con uno spazio che richiama l’agorà e lo stile armeno.
C’è un fonte battesimale molto particolare dove domina l’azzurro.
In una nicchia anche una scultura che rappresenta il diavolo.
In piazza Castello si trova il convento degli agostiniani ora museo civico e gipsoteca.
Il Castello è considerata una struttura militare molto interessante e fu caserma fino al 1999 quando il comune l’acquistò e ora viene usata per mostre e biblioteca per bambini.
Presenta due chiostri di cui uno è detto dei morti.
Ora è un complesso museale dopo la soppressione degli ordini religiosi sotto Napoleone.
Il Castello ha un fossato senza acqua: è stato costruito con aperture per le bombarde a sei diversi livelli d’altezza.
Un camino disperdeva velocemente i fumi delle bombarde. E’ rimasta una fortezza inviolata.
Una pecularietà del luogo è la presenza di “marna” da cui si ricava calce da cemento e per questo era chiamata la città bianca.
Nel periodo Napoleonico in Italia c’erano circa 25.000 ebrei che tra il venerdì Santo e la Pasqua potevano essere malmenati.
Nel “Museo dei Lumi”, nella parte più bassa della sinagoga, si possono vedere molte Menorah di forme diverse realizzate da vari artisti (Luzzati, Pomodoro, ecc.)
Quello che hanno in comune sono le sette braccia a simboleggiare la creazione con sei giorni di lavoro e uno di riposo.
Uno stoppino centrale detto “servitore” permette di accendere le tre + tre candele laterali.
Dopo la sinagoga e prima della visita a Casale, un ricco gustoso pranzo molto apprezzato.
Gemma Casanova